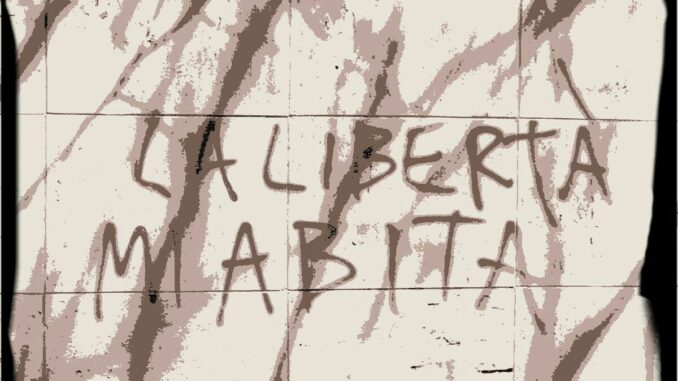
di Andrea Filloramo
Ogni giorno, scorrono davanti ai nostri occhi, attraverso lo schermo televisivo, le forti immagini di guerre, che avvengono in luoghi vicini a noi.
Esse con il carico di sofferenze, di distruzione e di morte, parlano alla nostra coscienza, poiché ogni guerra dovunque essa si svolga vicino o lontano, non è solo un evento storico o politico, sul quale molto si discute, ma è un forte confronto etico che ciascuno di noi è chiamato ad affrontare, che mette a nudo le nostre convinzioni, i nostri valori, la nostra idea di giustizia e di umanità, la capacità o la volontà di rispettare e garantire la pace dentro e fuori di noi.
Davanti agli orrori, ai dolori, alle ingiustizie che la guerra porta con sé, perciò, ognuno si chiede: da che parte sto? Cosa posso fare? Posso rimanere in silenzio? Devo prendere parte alle manifestazioni contro il “riarmo”, che incentiva il commercio delle armi, ma viene motivato da una presunta necessità strategica? E’ questa una decisione realmente efficace al raggiungimento del fine della sicurezza e della pace?
E’ difficile rispondere a quest’ultima domanda.
Sarebbe necessario fare l’analisi delle componenti dell’idea classica di deterrenza, che, in molti casi, confonde il fine con i mezzi.
Gli arsenali dovrebbero essere un mezzo per raggiungere il fine
Si tenga conto del fatto che la deterrenza si fonda sull’idea che forti forze difensive possano convincere la parte opposta a non attaccare e richiede che le forze che si interpongono tra l’avversario e il suo obiettivo siano sufficienti – in numero, mezzi e qualità – a resistere alle capacità nemiche, altrimenti l’effetto deterrente non potrà esserci.
Occorre forse abbandonare l’idea astratta della pace che è, sì, un ideale a cui aspirare, che implica, però, un’armonia condivisa, che, in questo momento, non è raggiungibile.
L’unica strada ancora da indicare e da seguire è quella della diplomazia, il cui sevizio risiede nell’invitare i singoli e i popoli a riscoprire il senso e le radici del proprio agire, il perché delle scelte e l’anelito verso la concordia, così come ci insegna Papa Francesco, che è l’unico leader spirituale del mondo, nell’Enciclica Fratelli tutti: «La carità politica – scrive Papa Bergoglio – consiste nell’apertura a tutti. Specialmente chi ha la responsabilità di governare, è chiamato a rinunce che rendano possibile l’incontro, e cerca la convergenza almeno su alcuni temi»
Occorre sperare, anche “contra spem”, che questo desiderio del Papa diventi il proposito di coloro ai quali è affidato il destino del mondo.



